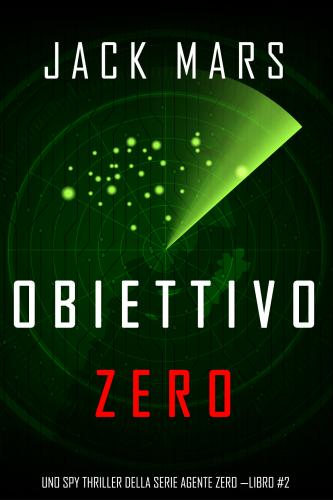Poi… un altro ricordo gli lampeggiò davanti agli occhi.
La cucina in Virginia. Kate è arrabbiata, sta indicando qualcosa sul tavolo. Non è solo arrabbiata, è spaventata. “Perché hai una cosa del genere, Reid?” chiede in tono accusatorio. “E se una delle ragazze l’avesse trovata? Rispondimi!”
Allontanò la visione prima dell’arrivo dell’inevitabile emicrania, ma ciò non rese l’esperienza meno inquietante. Non riusciva a ricordare quando o perché fosse avvenuto quel litigio; lui e Kate avevano discusso di rado, e nel ricordo lei era sembrata spaventata. Doveva aver avuto paura di quello per cui stavano litigando, o forse persino di lui. Ma non le aveva mai dato motivo per temerlo. Almeno non che riuscisse a ricordare…
Gli tremarono le mani quando fu colpito da un nuovo pensiero. Non riusciva a ricordare l’evento, il che significava che doveva essere tra quelli soppressi dall’impianto che gli avevano messo nel cranio. Ma perché una memoria riguardante Kate era stata cancellata insieme all’agente Zero?
“Papà!” Maya lo chiamò dal fondo delle scale. “Arriverai in ritardo.”
“Sì,” borbottò. “Vengo.” Prima o poi doveva affrontare la realtà: o cercava una soluzione al suo problema, oppure quelle memorie occasionali avrebbero continuato a tornare alla superficie, confuse e scioccanti.
Ma ci avrebbe pensato più tardi. In quel momento aveva una promessa da mantenere.
Andò al piano di sotto, baciò entrambe le figlie sul capo e si diresse verso l’auto. Prima di attraversare il vialetto, si accertò che Maya avesse attivato l’allarme dietro di lui, e poi salì sul SUV argentato che aveva comprato un paio di settimane prima.
Anche se era molto nervoso ed emozionato di vedere di nuovo Maria, ancora non riusciva a liberarsi dalla stretta di panico nello stomaco. Non riusciva a evitare di pensare che lasciare da sole le figlie, anche se per poco, fosse una pessima idea. Se gli eventi del mese precedente gli avevano insegnato qualcosa, era che innanzitutto aveva moltissimi nemici che desideravano vederlo soffrire.
CAPITOLO TRE
“Come si sente stasera, signore?” chiese educatamente l’infermiera del turno di notte entrando nella camera d’ospedale. Rais sapeva che si chiamava Elena ed era svizzera, anche se gli parlava in un inglese accentato. Era minuta e giovane, molti l’avrebbero definita persino attraente, ed era piuttosto allegra.
Rais non disse nulla in risposta. Non lo faceva mai. Si limitò a fissarla mentre lei appoggiava una tazza di plastica sul suo comodino e gli controllava con attenzione le ferite. Era consapevole che l’allegria serviva a compensare la paura. Era ovvio che non le piacesse stare in quella stanza insieme a lui, nonostante le due guardie armate alle sue spalle, che guardavano ogni sua mossa. Non era felice di curarlo, né di parlare con lui.
Nessuno lo era.
L’infermiera, Elena, ispezionò con cautela le sue ferite. Era ovvio che fosse nervosa standogli tanto vicina. Sapevano tutti che cosa aveva fatto, che aveva ucciso in nome di Amun.
Sarebbero molto più spaventati se sapessero quante persone ho ammazzato, pensò sarcastico.
“Sta guarendo bene,” gli stava dicendo. “Più velocemente del previsto.” Glielo ripeteva ogni sera, cosa che lui interpretava come un modo per dire: “Con un po’ di fortuna te ne andrai presto.”
Non erano buone notizie per Rais, perché quando finalmente fosse stato abbastanza in salute da andarsene, di certo sarebbe stato mandato in un orrendo e squallido buco scavato nella terra, una prigione segreta della CIA nel deserto, per subire nuovi strazi mentre lo torturavano per ottenere informazioni.
In quanto Amun, noi sopportiamo. Era stato il suo mantra per più di un decennio della sua vita, ma non era più così. Amun non esisteva più, per quanto ne sapeva; il piano a Davos era fallito, i suoi capi erano stati imprigionati o uccisi, e ogni organo di polizia al mondo sapeva del marchio, il glifo di Amun che i suoi membri si erano bruciati nella pelle. Rais non aveva il permesso di guardare la televisione, ma captava notizie dalle sue guardie armate, che chiacchieravano spesso (e a lungo, con sua grande irritazione).
Lui stesso si era tagliato via il marchio dalla pelle prima di essere portato all’ospedale a Sion, ma alla fine era stato tutto inutile; sapevano chi era e almeno una parte di ciò che aveva fatto. Nonostante ciò, l’irregolare cicatrice rosata sul braccio dove un tempo aveva avuto il marchio era un perpetuo ricordo che Amun non esisteva più, e quindi sembrava solo giusto che il mantra cambiasse.
Io sopporto.
Elena prese la tazza di plastica, piena di acqua fredda e con una cannuccia. “Vuole bere un po’?”
Rais non disse nulla, ma si sospinse in avanti e aprì le labbra. La donna guidò con cautela la cannuccia verso di lui, tenendo le braccia completamente estese, i gomiti rigidi e il corpo reclinato all’indietro. Era spaventata; quattro giorni prima l’assassino aveva tentato di mordere il dottor Gerber. Gli aveva solo graffiato il collo con i denti, non lo aveva nemmeno fatto sanguinare, ma il gesto gli aveva fatto ricevere un pugno alla mascella da una delle guardie.
Quella volta non cercò di fare nulla. Prese lunghe e lente sorsate attraverso la cannuccia, godendosi la paura della giovane donna e la tensione dei due agenti di polizia alle sue spalle. Quando ebbe bevuto abbastanza, si sdraiò di nuovo. Lei emise un percettibile sospiro di pensiero.
Io sopporto.
Aveva sopportato molto nelle ultime quattro settimane. Aveva subito una nefrectomia per rimuovere un rene perforato e un secondo intervento chirurgico per estrarre una parte del suo fegato lacerato. Poi c’era stata una terza procedura per accertarsi che nessuno degli altri organi vitali fosse danneggiato. Era rimasto diversi giorni in terapia intensiva prima di essere trasferito nel reparto di chirurgia, ma non aveva mai lasciato il letto al quale era ammanettato per entrambi i polsi. Gli infermieri lo giravano, gli cambiavano la padella e lo tenevano più comodo possibile, ma non aveva il permesso di sollevarsi, di alzarsi e di muoversi di sua volontà.
Le sette ferite da taglio sulla sua schiena e quella sul suo petto erano state suturate e, come Elena, l’infermiera notturna, gli ricordava di continuo, stavano guarendo bene. Tuttavia, non c’era molto che i dottori potessero fare per i danni ai nervi. A volte tutta la spina dorsale gli si intorpidiva fino alle spalle e di tanto in tanto persino fino ai bicipiti. Non sentiva nulla, come se quelle parti del suo corpo fossero state di qualcun altro.
Altre volte si svegliava da un sonno profondo con un urlo in gola e un dolore bruciante che lo attraversava come una tempesta di lampi. Quegli attacchi non duravano mai a lungo, ma erano acuti, intensi e si ripetevano a intervalli irregolari. I dottori li definivano “dolori neuropatici”, un effetto collaterale che poteva capitare a chi aveva subito danni ai nervi tanto estesi. Gli avevano assicurato che spesso si attenuavano e sparivano del tutto, ma non gli avevano potuto dire quando sarebbe successo. Invece lo avevano informato che era stato fortunato a non aver riportato danni alla spina dorsale, e ad essere sopravvissuto alle sue ferite.
Già, fortunato, pensò amaramente. Fortunato di essere in via di guarigione, solo per finire sepolto in una prigione segreta della CIA. Fortunato che tutto ciò per cui aveva lavorato gli fosse stato strappato in un solo giorno. Fortunato ad essere stato sconfitto non solo una volta, ma due, da Kent Steele, un uomo che disprezzava e odiava con ogni fibra del suo essere.
Io sopporto.
Prima di lasciare la sua camera, Elena ringraziò i due agenti in tedesco e promise a entrambi di portar loro del caffè quando fosse tornata più tardi. Una volta che si fu allontanata, gli uomini riassunsero le loro posizioni fuori dalla porta, che era sempre aperta, e ripresero la loro conversazione, qualcosa su una recente partita di calcio. Rais conosceva bene il tedesco, ma i dettagli del dialetto svizzero-tedesco e la velocità con cui parlavano a volte lo eludevano. Gli agenti del turno di giorno tendevano a parlare in inglese, ed era grazie a loro che otteneva la maggior parte delle notizie su ciò che succedeva fuori dalla