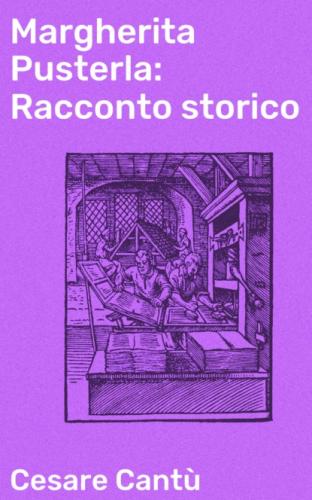La rincrescevole attenzione e il frequente rivolgersi del principe non isfuggirono al Pusterla, il quale, voltosi ai non meno accorti compagni, domandò loro:—Vedeste?
—Vidi», rispose il frate chinando le ciglia in atto di persona abituata a gravi pensieri.
—Sfacciato!» saltava con occhi sfavillanti il giovane.—Quest'altra ci mancava! Ma che non può aspettarsi da un tiranno? Oh perchè non ci ha a Milano cento persone deliberate al par di me! E voi, oh perchè non vi risolvete, signor Francesco, di far suonare alto il vostro nome e metter fine alle servitù della patria ed all'obbrobrio comune?»
Franciscòlo Pusterla col gesto e colla voce imponeva silenzio ad Alpinòlo (quest'era il nome del garzone), mentre il frate, colla posatezza abituale alle persone costrette a riflettere, a concentrarsi, a vivere in sè, diceva:—All'uomo scontento rimane un partito! spiccarsi dai viziosi, e senza paventare la dimenticanza de' suoi concittadini, cercare nella dignitosa ilarità de' domestici affetti la pace e la sicurezza della coscienza e del proprio onore. Così ha saputo fare tuo suocero Uberto Visconti: così avresti a far tu: e mille segni ti mostrano che n'è venuta l'ora. Con un tesoro qual è la tua Margherita, non è angolo del mondo così riposto, non solitudine così romita, che non ti possa convenire in un paradiso».
La voce del frate erasi animata a questo parlare, come anche il color delle guancie; egli se n'avvide, chinò il capo e tacque. Ma Franciscòlo, punto non mostrandosi convinto alle parole dell'amico:—Sì, frà Buonvicino (diceva); ritirarmi, questo è il sogno delle mie veglie. Ma poi? cos'è mai un uomo fuor degli affari? Come parrei dirazzato da' miei padri, sempre attenti alle pubbliche cure! Finchè il signor Azone governò, sai se continuamente adoperai al bene della mia patria; sai se fin d'allora ho usato ogni maniera di riguardi dilicati a questo Luchino, benchè fosse in urto collo zio, nella fiducia che, giungendo alla sua volta al comando, me ne saprebbe buon grado, mi terrebbe fra' suoi vicini, e così potrei dirizzarlo al meglio comune. Or vedi frutto! Appena impugnò quel bastone del comando, che tanto noi oprammo, per affidargli, non che dimenticare i meriti nostri recenti, fino gli antichi pare ci ascriva a colpa: e sbalzati noi tutti, si è posto attorno gente nuova e plebea, assurda consigliera, insana adulatrice, feccia tale, che mille miglia ne vorrei esser lontano, se non mi trattenesse la speranza di tornar utile alla famiglia mia, ed ai miei concittadini».
Applaudiva Alpinòlo a quel risentito parlare: ma frà Buonvicino, avvisando che, sotto al velo dell'utile pubblico, s'ascondevano l'ambizione e un naturale, che, non sapendo provare godimenti se non nella tempesta, metteva a pari la calma e la morte, trovava facilmente come ribattere le apparenti ragioni dell'amico, ma non come destargli una virile vergogna: onde, qual persona usata a concedere indulgenza alle debolezze degli uomini per non essere costretto a doverle disprezzare, finiva col seguitarlo tacendo, finchè si divisero allo sbucare sulla piazza del Duomo.
Se però volete figurarvi al vero gli uomini di quel tempo, vestiti di ferro e di sfarzosi mantelli, e pellicce, e collane d'oro, e berretti a piume ondeggianti, e spadoni ai fianchi, ed enormi mazze ferrate agli arcioni, e sul guanto astori e falchi, non dovete collocar loro d'attorno queste fabbriche d'oggidì, le vie larghe, allineate, selciate che sasso non eccede, fiancheggiate da case a tre o quattro solaj, colle finestre simmetriche, protette da gelosie, con botteghe d'ogni lusso, con tutta quella bellezza che ha per carattere il gentile, e che rivela tempi quieti, gente educata a non pensare gran fatto all'avvenire. L'architettura, come sempre fa, erasi foggiata ai costumi e alle opinioni correnti, tutta solidità nei palazzi, nel resto appena quel che fosse necessario per riparare dalle intemperie la plebaglia, perpetuamente condannata a faticare e patire, giovare ed essere disprezzata. Alte e massiccie torri accanto a bassi tugurj, pareano simbolo della società, divisa in due condizioni, una altissima, infima l'altra. Le poche abitazioni che si elevassero sopra il pian terreno, s'intitolavano solari; e da uno appunto di siffatti aveva ricevuto il nome la chiesa di Sant'Ambrogino in Solariolo, che fu poi detto alla Balla, da un atrio ove, tre volte alla settimana, tenevasi mercato d'olio, di pollami e latticinj. Colà presso può vedersi ancora[4] uno di quei torrazzi, che ajutano l'immaginazione a ricostruire il Milano antico; e da non molto tempo fu diroccato l'altro che faceva cantonata alla via che volge a Sant'Alessandro. Formava esso parte dello splendido palazzo dei signori Pusterla, il quale distendeasi fino all'Olmetto e ai Piatti, in apparenza più di fortezza che di abitazione. Tutto di pietre tagliate, verso la strada non aveva che due finestre alte, protette da robuste inginocchiate, siccome chiamavano le ferriate sporgenti a pancia: grossi anelli impiombati nelle bugne offrivano la comodità di legarvi i cavalli, per salir sui quali erano disposti lungo i muri ed alla porta, dei dadi di granito; la porta chiusa con enormi battenti ferrati e col suo ponte levatojo, aprivasi sotto una torretta quadrata, posta in fondo alla via mozza, che ancora nominiamo Vicolo Pusterla. Sull'accennato torrione di angolo sventolava lo stendardo della famiglia, coll'aquila nera in campo giallo; e dal mezzo ne sportava il verone, sul quale si era mostrata la signora Margherita. I Pusterla, famiglia delle più nobili e la più ricca di Milano, avevano nei tumulti antecedenti parteggiato ora coi Torriani ora coi Visconti: Matteo Magno aveva sposata una figliuola di Filippo Torriani, dalla quale era nato il Franciscòlo di cui parlammo.
Trascorso quel palazzo, la cavalcata tirò innanzi per la via de' Banderaj, detta poi de' Pennacchiari, indi per quella che fu poi nominata dei Mercanti d'Oro per le botteghe dei tessuti d'oro e seta, introdotti appunto dominando Luchino[5]. Le vie erano state, fin dal 1272, solate a mattoni per taglio o acciottolate: poi il signor Azone aveva fatto scavare cloache per tenerle monde, e ordinato che restassero sgombre da sozzure e impedimenti: ma altro è ordinare, altro è essere obbedito. Ove le fitte case lasciassero un poco di largo, il sole versava la limpida sua luce: ma generalmente basse tettoje ed acuminate, sporgendo in brutta guisa, se salvavano dalla pioggia il pedone e gl'indifesi balconi, impedivano però il circolare dell'aria e davano sgradevole vista.
Dalle anguste o distorte vie mal argomentereste la miseria della città; che quanto anzi fosse ricca e popolosa ce ne dà indizio una statistica di quei giorni. Contava essa (per dirne alcun che) tredicimila porte con seimila pozzi, uno più uno meno: quattrocento forni di pane, s'intende di mescolanza, che pel bianco n'aveva uno solo alla Rosa; mille taverne, oltre cencinquanta locande: tremila macine da molino, servite da seimila bestie da soma: a duecentomila salivano gli abitanti, di cui un quinto atti alle armi, ducento causidici, altrettanti medici, mille notaj, settanta maestri d'elementi, quindici di grammatica e logica, cinquanta copisti di libri, i Remondini ed i Bodoni di allora; oltre ottanta fabbri-ferraj e maniscalchi, quattrocento beccai, trecentottantacinque pescivendoli, trenta fabbricatori di sonagli, cento d'armadure, e innumerabili lavoratori, negozianti e ritagliatori di panni e di sete, per cui comodità si tenevano quattro fiere all'anno e mercati quotidiani.
Non accompagnerò in altre minuzie lo statistico, il quale sa fin dirvi che si consumavano in città ogni anno cinquantamila carra di legna, il quadruplo di fieno, seimilacinquecento staja di sale: ogni settimana si ammazzavano da settanta a ottanta bovi ingrassati; e al tempo delle ciliegie ne entravano sessanta carra al giorno; che nella sola città si numeravano seimila novecento quarantotto cani; fra la città e la campagna cento astori nobili e il doppio falconi, oltre sparvieri senza numero.
Io che, per prova, non mi fido alle cifre esibite dalle statistiche odierne, molto meno voglio spacciarvi per di fede queste d'allora: bastandomi vi diano in di grosso un'idea del quanto allora si vivesse diverso dal presente.
Ancor più diversi erano gli uomini che popolavano la Lombardia e tutta Italia. Prima di ogni altra nazione si erano alzati dall'invilimento, cui gli avevano ridotti le orde settentrionali: il commercio, le navigazioni, le ricordanze e i resti degli antichi municipj, la necessità della difesa, le lettere, la religione gli avevano ajutati a costituirsi in altrettante repubbliche quante erano le città.
La lotta degli imperatori tedeschi non fece che consolidare la civile e la politica libertà, fra cui si svilupparono le forze tutte del corpo, del cuore, dell'intelletto. Soldati valorosissimi, i più arditi marinaj, i più lauti negozianti, essi ridestarono la pittura, l'architettura, la