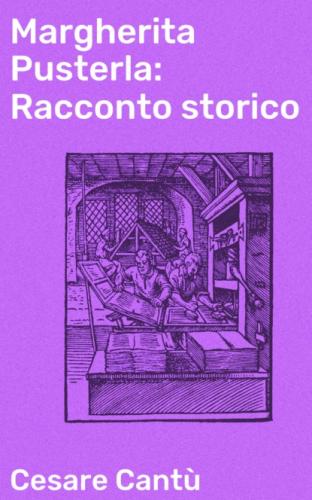Che i sudditi lo amassero glielo ripetevano cagnotti, ambasciatori e poeti: quanto egli sel credesse potevasi argomentare dal giaco di maglia che mai non deponeva, dalle raddoppiate guardie, e da due enormi alani, che, come i soli non capaci di desiderare miglioramento nè libertà purchè mangiassero, si teneva ai fianchi dovunque andasse.
Pure, al veder le dimostrazioni che gli facevano in quel tragitto per la città, avreste potuto supporre Luchino un padre del suo popolo. E non tutte dovevano dirsi adulazioni e vigliaccheria. Nessun governo si dà che sia tristo affatto, nessuno che non profitti a qualche classe. I Lombardi erano corsi attraverso un'età d'interne turbolenze, ove la libertà, acquistata a prezzo di sangue e di sforzi generosi, erasi andata guastando tra fraterni dissidi, ire di fazioni, soperchierie di prepotenti: talchè, stanchi d'un assiduo tempestare ove il grosso del popolo arrischiava tutto senza nulla vantaggiare, vedeano di buon occhio un governo robusto che poneva un freno a tutti, si avvezzavano a chiamare pace la comune servitù, come la chiamavano libertà quelli che ne facevano il fatto loro. Luchino, inoltre conferiva gl'impieghi quasi solo a nostrali, talchè seimila cittadini vivevano sopra i pubblici stipendj: nella carestia che allora affliggeva il paese, quarantamila bisognosi erano mantenuti a spese della città: della città dico, non del principe: ma il popolo è sempre disposto ad attribuire a questo i beni come i mali che prova.
Quanto ai nobili, erano impazzati nel tempo che regolavano il pubblico interesse: ciascuno amò sè più che la patria, più le proprie soddisfazioni che le comuni libertà, più il comodo che la gloria, più la vita che la virtù: ora mangiavano del cibo che s'erano preparato. Alcuni, vedendo di non potere nè sopportar così, nè volgere in meglio la sorte del loro paese, o viveano ritirati in violenta pace, od uscivano in esteri paesi: col che più libero lasciavano il campo all'ambizione di coloro che, non più nella patria, ma alla Corte cercavano primeggiare, operando non all'utilità di tutti ma di quel solo da cui ricevevano o speravano lustro e ricompense.
Se non che Luchino, o insospettito o geloso, aveva dato lo sfratto a tutti coloro che erano stati in auge sotto di Azone, per attorniarsi di nuova brigata sul far suo, compagni alle sue giovanili dissolutezze, disposti a fare com'egli voleva e peggio. Nella cavalcata che noi descriviamo, si potevano discernere i nuovi dagli scaduti al rimanere quelli vicini al principe, e tal ora accostategli pronunziando qualche parola; allo sfoggiare in pompa di codardia; allo stringersi fra loro baliosi, e celiare, e sbizzarrire sui briosi palafreni; mentre gli altri si tenevano estremi, taciturni e fra loro scambiando qualche parola sommessa e dispettosa. La plebe naturalmente supponeva senno, valore e prudenza nei favoriti dal principe, il contrario negli altri: sberretteva i primi, assomigliava gli ultimi a patarini e scomunicati; e tenuta indietro dal ceffo arcigno del tedesco Sfolcada Melik, capitano alla guardia del corpo di Luchino, sbirciando sott'occhio quel muso baffuto, gridava:—Viva il Visconti, viva il biscione!»
Senza discernere gl'infimi dai sommi, tra la parata galoppava un buffone, razza di cui ogni Corte era provvista e più lautamente la milanese, che in simile genia spendeva ogni anno trentamila fiorini[3];—ottimo uso delle pubbliche entrate. Vi facevano costoro l'uffizio, che altre volte adempirono i poeti e sempre gli adulatori; lisciar i padroni, far ridere alle proprie spalle, trattenere con imbecillità corruttrici e velar l'orrore d'un delitto sotto la vivacità d'un'arguzia. Se non che (tanto in ogni istituzione vanno misti il male e il bene) in mezzo ai loro lazzi avventuravano qualche verità, che altrimenti non sarebbe giunta fino alle orecchie dei gran signori. Grillincervello, come chiamavasi il buffone di Luchino, copriva la zucca monda con un berretto bianco a cono, sormontato da un cimiero scarlatto a guisa di una cresta di gallo; con due brache e un farsettaccio di traliccio larghi e sciamannati, con enormi bottoni e ciondoli sonori; ed impugnava un bastone, il cui pomo figurava una testa di pazzo colle orecchie asinine. Messosi per isproni due ravanelli (fabbrica di Pavia, com'esso diceva), stuzzicava con essi un orecchiuto destriero di Barlassina (altra sua frase), tutto a fiocchetti e sonagliuzzi; e colla bocca atteggiata sempre a un riso fra idiota e maligno, con certi occhi sgranati e guerci, saltabellava di qua, di là, or dando la caccia ai porcelli e alle galline che liberamente pascolavano per le vie; ora ficcandosi attraverso ai passi del terzo e del quarto, e scagliando a questo un motto, a quello una zaffata. Farfogliando al Melik qualche frase mezzo tedesca, gli tirava i severi mustacchi, e mentre colui, senza scomporre di sua gravità, gli assestava una sciabolata di piatto, egli era guizzato un pezzo lontano. A Matteo Salvatico (scrittore dell'Opus pandectarum medicinæ, la più diligente opera intorno alla virtù delle erbe), il quale, secondo il lusso de' medici, cavalcava con un vestone di porpora e preziosi anelli e sproni dorati, il buffone, facendo al suo somarello un cenno ch'io non voglio descrivere, diceva:—Toccagli il polso»; poi indirizzandosi all'astrologo Andalon dal Nero, altro mobile indispensabile delle Corti d'allora, il quale procedeva contegnoso e sopra pensieri, gli batteva in sulla nuca, dicendo:—Questa non te l'avevano indovinata le stelle».
Lo udiva Luchino, e ne sorrideva, sinchè, passato appena il palazzo che egli aveva eretto per propria abitazione da privato in faccia a San Giorgio, ed inoltrandosi fra la turba che, presso alla chiesa di Sant'Ambrogino in Solariolo, affollavasi al mercato, o come dicevano, alla Balla degli olj e dei laticinj, cominciò a fissare gli occhi sopra una signora, che stava sur un terrazzino, sporgente dalla torre in angolo della via che di là mette a Sant'Alessandro. Questa era Margherita Pusterla, anch'ella di casa Visconti e cugina del principe, ma troppo da lui dissomigliante. Erasi fatta ad osservare il corteggio, non per capriccio di femminile curiosità, ma per cercare fra questo il marito suo Franciscolo Pusterla, uno, come abbiam detto, dei vincitori della giostra, e che teneasi in fondo tra gli scontenti. La dama, la quale era tutto il bello che dev'essere l'eroina d'un racconto, reggeva sulla spalletta del verone un caro fanciullo di forse cinque anni: e tendendo la destra candida e morbida come di cera, gli additava lontano un cavaliero superbamente vestito e montato, alla cui vista il bambino, trasalendo di gioia fra il seno e le braccia materne, esclamava:—Babbo! babbo!» e con ingenuo vezzo infantile sporgeva verso quello le braccia. Assorta in quest'episodio di famiglia che per lei era tutto, la Margherita non poneva mente nè agli applausi del vulgo, nè alla pompa del corteo, nè agli occhi che ammiravano la sua bellezza, nè a Luchino, sebbene questi, allorchè fu sotto al balcone, avesse rallentato il passo, e fatto sbraveggiare e atteggiar vagamente il superbo stallone bianco che cavalcava, bramoso di attirarsi uno sguardo della bella.
Ma invano: onde una nube di dispetto gli passò sul volto severo. Se non che Ramengo da Casale, uno dei cortigiani sempre disposti a piaggiare, qualunque essa sia, la passione dei potenti, si fece accosto a lui, ed inchinandolo con adulatoria sommessione, esclamò:—Se vuolsi trovare qualcosa di grande negli uomini, o qualcosa di bello nelle donne, è forza ricorrere al nome de' Visconti».
Luchino, non mosso dall'incensata che come uomo avvezzo alle vigliaccherie, rispose:—Sì: ma a costei pare che puta il nostro cognome: nè voi altri fra quanti siete sapeste mai farne belli i circoli nostri.
—Vero! (ripigliava Ramengo) Ella è tanto schifa ed orgogliosa quanto bella ed aggraziata. Ma più la vittoria è difficile, più torna a onore, e ad un sospiro del principe qual ritrosia durerebbe?»
Guizzò fra loro il buffone, e ghignando beffardamente sul viso dell'adulatore, poi di Luchino, disse a questo, vagliando la persona in modo da sonar tutto:—Non dargli ascolto, padrone; leccane i barbigi, che non la è carne pe' tuoi denti.
—E perchè no, sfacciato?» saltò su mezzo in collera Luchino.
—Perchè no», ripetè il mariuolo, e toccata la cavalcatura, in un batter d'occhio fu lontano, mentre Luchino, senza curare nè le piacenterie dei cortigiani, nè i viva del popolo, seguitava innanzi a rilento, volgendosi tratto tratto verso la signora Pusterla. Essa invece non distoglieva gli occhi dal marito, il quale procedeva fra un giovine e un frate, che pedestri uscitigli incontro, l'accompagnavano discorrendo. Il giovane era tutto fuoco nel gesto, negli sguardi, nel favellare; la faccia dell'altro, composta a gravità severa e pur dolce, annunziava una lotta profonda ma calma