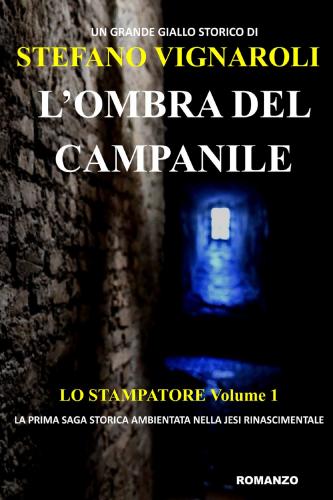Incupita da queste riflessioni, impaurita da ciò che aveva visto, Lucia afferrò la lanterna e si precipitò su per le scale, con la mente occupata da un solo timore. Avrebbe ritrovato la porta aperta? E se lo zio si fosse ricordato di non averla sbarrata e fosse ritornato a chiuderla? O se magari lo avesse fatto apposta, per indurla ad andare là sotto e seppellirla viva? No, non sarebbe stato abbastanza per Artemio, lui doveva vedere in faccia la sofferenza della propria vittima, non sarebbe stato da lui lasciarla morire lì. Voleva solo spaventarla, e c’era riuscito. La porticina di legno era aperta, Lucia uscì nell’androne, ripose la lanterna dove l’aveva presa, non degnò Morocco neanche di uno sguardo e si precipitò all’aria aperta, nella Piazza, ancora col cuore in gola.
Era quasi il tramonto di una calda giornata di fine maggio e la luce rossastra del sole donava dei colori spettacolari alla stupenda piazza in cui più di tre secoli prima era nato l’imperatore Federico II di Svevia. Disse a se stessa che avrebbe dovuto ricercare il significato dei simboli rinvenuti nella cripta nel Diario di famiglia, in quel prezioso manoscritto che le aveva consegnato la nonna. Ma ora doveva calmarsi, e decise di fare due passi per la città. Attraversò la piazza, raggiungendo il lato opposto, svoltò a sinistra e discese per la Costa dei Longobardi, per raggiungere la parte a valle del centro abitato, dove vivevano mercanti e artigiani. I palazzi erano meno sontuosi rispetto a quelli della parte alta della città, ma erano comunque arricchiti di elementi decorativi, con rifiniti portali e cornici intorno alle finestre. Le facciate erano quasi tutte abbellite dall’intonaco, pitturato in colori pastello, quali celeste, giallo, ocra, arancione tenue; era difficile che venissero lasciate in mattoni faccia a vista, come invece era per i palazzi signorili su al centro. A ricordare che quelle dimore erano state costruite grazie ai soldi guadagnati da chi vi abitava, spesso sugli architravi dei portali o delle finestre del primo piano comparivano delle scritte come “De sua pecunia” o “Suum lucro condita – Ingenio non sorte”. In fondo alla Costa dei Longobardi, svoltando a destra, in breve si poteva raggiungere la chiesa dedicata all’apostolo Pietro, fatta edificare proprio dalla comunità Longobarda residente a Jesi nella seconda metà del secolo decimo terzo. “Principi Apostolorum – MCCLXXXXIIII”, si leggeva sopra il portale; chi aveva inciso la data non aveva più molta memoria di come andassero scritti i numeri in latino, o forse non l’aveva mai saputo essendo un architetto di origine bizantina, abituato già ad avere a che fare con le cifre arabe, molto più semplici da memorizzare. Di fronte alla chiesa, il Palazzo dei Franciolini, appena finito di costruire, era la residenza del Capitano del Popolo, Guglielmo dei Franciolini. Anch’egli aveva fatto la sua fortuna come mercante dato che, dopo la scoperta del Nuovo Mondo, nuovi canali commerciali erano sati aperti e molte nuove mercanzie erano giunte anche a Jesi. Chi aveva potuto aveva approfittato, ed era riuscito in poco tempo ad accumulare notevoli ricchezze. Lucia si soffermò sul ricco portale del palazzo, limitato da due colonne e da alcune piastrelle quadrate di pietra arenaria, decorate con raffigurazioni di Dei e simboli dell’epoca romana.
Con tutta probabilità, nello scavare le fondamenta dell’abitazione, erano stati rinvenuti elementi decorativi di una casa di qualche patrizio romano, e questi erano stati riutilizzati per abbellire il portale. Lucia riconobbe il Dio Pan, Bacco, la Dea Diana, e poi ancora dei gigli a tre punte, e… una stella a sei punte formata da due triangoli incrociati tra loro - strano, non era forse il simbolo degli ebrei? – e ancora una stella a cinque punte, un pentacolo, e… un disegno a sette punte inscritto in un cerchio, simile in tutto e per tutto a quello che aveva visto poco prima nella cripta. Questi ultimi disegni non potevano risalire all’epoca romana, e infatti, osservando con attenzione le piastrelle su cui erano realizzati, si notava che queste erano di fattezza diversa, più recenti rispetto alle altre, forse realizzate all’uopo per decorare il portale. Ma che significato aveva tutto ciò? In quella piazzetta conviveva il sacro con il profano: da un lato la chiesa dedicata al principale degli apostoli, a Pietro, il primo Papa della storia del cristianesimo, dall’altro figure pagane e simboli che potevano accusare il padrone di casa di essere un eretico. Eppure lo zio Cardinale era in buoni rapporti con il Franciolini, addirittura le aveva proposto il figlio come suo futuro sposo! Più guardava quei simboli, più Lucia pensava che quel luogo avesse qualcosa di magico. Forse quel palazzo era stato costruito sopra i ruderi di un tempio pagano, e aveva mantenuto le sue peculiarità. Cercò di concentrarsi, di aprire il suo terzo occhio alla veggenza, invocò il suo spirito, per farlo librare in alto e scrutare elementi che altrimenti non avrebbe visto. Già tra le sue mani disposte a coppa si stava materializzando la palla semifluida dai colori variopinti, quando il portone del palazzo si spalancò all’improvviso, mostrando nella penombra un giovane che indossava una leggera armatura da battaglia, a cavallo di un potente destriero a sua volta bardato in testa a protezione di eventuali colpi che potevano essere inferti da spade e lance.
Il cavaliere reggeva con la mano destra il gonfalone della Repubblica Jesina, rappresentante il leone rampante ornato dalla corona regale. Non appena il portone fu del tutto aperto, spronò il cavallo all’esterno, quasi travolgendo Lucia che era lì davanti. La ragazza, spaventata, si deconcentrò, e la sfera subito scomparve. Il cavallo, di fronte all’ostacolo imprevisto, si impennò, scalciando in aria con le zampe anteriori. Lucia sentì uno zoccolo a brevissima distanza dal suo viso, ma non si lasciò prendere dal panico e infisse il suo sguardo negli occhi azzurro mare del cavaliere, che aveva la visiera dell’elmo sollevata. Per un attimo si perse in quegli occhi, il cavallo si acquietò e il cavaliere ricambiò lo sguardo alla damigella, fissando a sua volta gli occhi nocciola della ragazza. Ci fu un momento di calma, di totale silenzio, l’incrocio dei due sguardi sembrava aver fermato il tempo.
Chi era quel bel cavaliere, pronto a un’ipotetica battaglia in difesa della propria città? Era forse Andrea? Se così fosse stato, avrebbe dovuto essere grata al suo malvagio zio! Ma forse il Franciolini aveva altri figli. Non ebbe il tempo di aprire bocca, perché dopo pochi istanti, le campane della chiesa di San Pietro iniziarono a suonare, e a esse via via si unirono quelle della chiesa di San Bernardo, poi quelle di San Benedetto, e infine quelle di San Floriano. Lanciando un ultimo sguardo a Lucia, il cavaliere spronò di nuovo il cavallo, raggiungendo la limitrofa Piazza del Palio, l’enorme spiazzo all’interno delle mura, dominato dal Torrione di Mezzogiorno. In breve, altri cavalieri in armi si strinsero attorno a colui che stringeva in mano il gonfalone, poi arrivò anche gente a piedi, armata di balestre, pugnali e qualsiasi altra arma potesse essere usata contro il nemico.
«Gli anconetani ci stanno attaccando!», gridò il nobile Franciolini. «Li hanno avvistati le nostre vedette dal Torrione del Montirozzo. Oggi, 30 Maggio 1517, ci prepariamo a difendere le mura della nostra città.»
Tutte le porte furono chiuse, la maggior parte degli uomini a piedi si dispose sugli spalti, mentre i cavalieri si assiepavano nel piazzale all’interno di Porta Valle, pronti alla sortita contro il nemico. Ma per quella notte, l’esercito anconetano, guidato dal Duca Berengario di Montacuto, non si avvicinò a Jesi, rimase accampato più a valle, a poche leghe dal centro abitato di Monsano, seminascosto nella boscaglia ripariale in prossimità del Fiume Esino.
Per alcuni giorni rimase l’allerta. All’imbrunire le scolte raggiungevano gli spalti, a rafforzare la guardia di solito demandata ad alcune vedette, e dalle mura risuonava il richiamo di un canto che da parecchi anni la popolazione non sentiva più:
«Squilla la tromba che già il giorno finì,
già del coprifuoco la canzone salì!
Su, scolte, alle torri guardie armate, olà,
Attente, in silenzio vigilate!»
Il Capitano del Popolo aveva imposto il coprifuoco alla cittadinanza. Alle nove di sera, chi non saliva sugli spalti delle mura, aveva l’obbligo di ritirarsi in casa. Ma la guardia era destinata ad abbassarsi presto. Per la sera del 3 Giugno era prevista la festa a Palazzo Baldeschi, in cui sarebbe stato annunciato il fidanzamento della nipote del Cardinale, Lucia, con il cadetto di casa Franciolini. In quei giorni, ogni volta che Lucia incrociava gli occhi di suo zio,