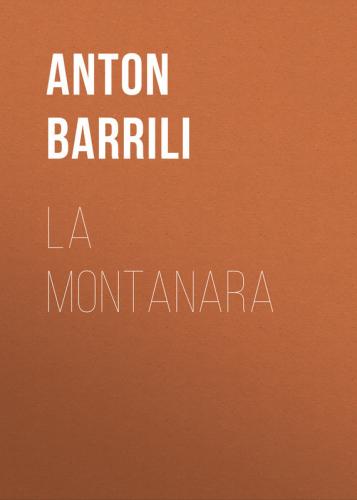E questo, ritornando a Modena, questo aveva comunicato, senz'aria di mistero, come senz'ombra di millanteria, a giovani della sua età, sebbene, come diceva il direttore di polizia, «non convenienti al suo grado.» Dèi buoni! Quelli erano stati i suoi compagni di studio, i suoi colleghi d'università. Come mai avrebbe potuto egli non considerare uguali coloro che erano stati seduti con lui sulla medesima panca, a sentire le medesime lezioni? Più saggi dei moderni, quantunque niente più fortunati, i tiranni antichi avevano lavorato a rendere la nobiltà ignorante. L'istruzione, a tutti egualmente impartita, accomuna le classi, colma gli abissi e sopprime i confini. Che conti e che marchesi? Queste distinzioni, quando non sono una giunta particolare e naturalissima al nome di famiglie veramente storiche (nel qual caso si potrebbero anche ommettere, senza toglier lustro a que' nomi), non hanno più valore che per le dame, essendo dimostrato che una corona di tre fioroni, o di nove perle, fa ancora un bel vedere sui biglietti di visita e sugli sportelli delle carrozze. Povera feudalità, ridotta ad un semplice ufficio decorativo! Ma siamo giusti, perbacco, e non dimentichiamo che la corona sullodata sta anche bene sulla biancheria, come a dire sui capi delle tovaglie e dei fazzoletti da naso.
Ai suoi buoni amici plebei, compagni d'università e fratelli di fede, il conte Gino Malatesti non aveva nulla da scrivere. L'offerta di Giuseppe non poteva dunque favorire la politica. Ma il pensiero di Gino, svegliato da quella offerta inaspettata, corse subito ad altro.
– Tu, dunque, – diss'egli, dopo un istante di pausa, – mi servirai fedelmente? Ad ogni rischio? E mio padre non saprà nulla? —
Ad ognuna di quelle domande aveva risposto con bella progressione di calore un sì del suo compagno di viaggio.
– Bene; – ripigliò il conte Gino; – tu puoi rendermi un servizio maraviglioso. Non mi hanno permesso di fare neanche un saluto, temendo forse che il saluto nascondesse Dio sa che cosa! Tu dunque andrai domani, o doman l'altro, al palazzo Baldovini, con un pretesto qualunque… Potresti, per esempio, riportare un libro, che mi è stato imprestato: il Mauprat, di Giorgio Sand, che è per l'appunto rimasto sul mio tavolino. Con questa scusa cercherai di vedere la marchesa Polissena, e potrai consegnarle il biglietto che io ti scriverò alla prima fermata.
– Non dubiti, illustrissimo; – rispose Giuseppe; – farò la commissione a dovere. Anche la signora marchesa, – soggiunse poscia, abbassando la voce, – è della buona causa? —
Gino trattenne in tempo una risata, che già gli faceva impeto alla gola. Ma era buio fitto, e Giuseppe non vide neanche la contrazione dei muscoli.
– Ah! – disse Gino. – È una dama di alto sentire. Tu le darai notizie di me, del modo in cui son dovuto partire da Modena. Forse domani la cosa sarà conosciuta; ma la marchesa deve sapere che io avevo tentato di vederla. Il biglietto, poi, come farglielo giungere?.. Se ti frugano, alle porte?.. Capirai che un sospetto può nascere…
– Sospetti su me, illustrissimo? Non ne hanno.
– Bravo! E come lo sai?
– Ne ho avuta la prova; – rispose Giuseppe, sospirando. – Si figuri che m'hanno domandato di fare… la spia. Ed io ho ricacciata la mia rabbia in corpo, ed ho lasciato credere che al bisogno avrei anche traditi i miei padroni. Volevano sapere chi bazzica in casa, che discorsi si fanno… Ed io ho detto tutto; s'immagini; non c'è niente da nascondere.
– Lo credo bene! – esclamò Gino. – Ma è strano, sai! È strano che non si fidino neanche di mio padre.
– Che vuole, illustrissimo? Così è; – rispose il servitore. – Ma io li ho serviti bene, da vecchio carbonaro.
– Carbonaro, tu, Giuseppe?
– A quei tempi, sì.
– E in casa di mio padre?
– Ho sempre fatto il mio dovere, signor conte.
– Lo so, e non parlavo per questo; – disse Gino. – Ti esprimevo la mia meraviglia e nient'altro. Chi lo avrebbe mai immaginato che ci fosse un carbonaro, in casa Malatesti!.. E nel Quarantotto, poi, come hai fatto a tenerti in corpo il tuo segreto?
– Amavo la casa, illustrissimo; amavo i figli del mio padrone, che erano cresciuti così belli e fiorenti sotto i miei occhi. Ma anche tenendomi il segreto in corpo, come Ella dice, ho fatto quanto era in me, per servizio della buona causa. Fu bene che avessi nascoste con tanta cura le mie opinioni, perchè, quando venne la restaurazione, nessuno dubitava del vecchio servitore di casa Malatesti, ed ho potuto rendere qualche grosso servizio ai patrioti.
– Bravo Giuseppe! Tu mi parli con una confidenza!
– Signor conte, Ella è dei nostri; – rispose Giuseppe. – Non la mandano in esilio, per questo?
– È vero; – disse Gino, che a quella parola «esilio» si sentiva crescere di qualche cubito nella propria estimazione. – Tu dunque sei per me l'inviato della provvidenza. E mi porterai il biglietto. Ma se ti frugano, laggiù?
– Se mi frugano, non troveranno un bel nulla. Ci son tanti modi di nascondere un pezzettino di carta! Lasci fare a me, signor conte; e nella rivolta della giacca, o nella fodera delle maniche…
– Bene, bene! – interruppe Gino. – Ne parleremo a Paullo. L'essenziale è di far sapere ciò che mi è occorso alla marchesa Polissena. —
L'idea di poter mandare un biglietto alla bella Baldovini calmò gli spiriti esacerbati del conte Gino, il quale finì con pigliar sonno. Quando si svegliò, la carrozza entrava a Paullo.
Il servitore avrebbe potuto accompagnarlo fino a Pievepèlago ed anche fino a Fiumalbo, dove, per andare a Querciola, sarebbe bisognato abbandonare la strada maestra. Ma il conte Gino preferì che Giuseppe ritornasse a Modena, tanto gli premeva di mandar sue notizie alla marchesa Polissena. E là, nell'osteria di Paullo, sopra un foglietto di carta, strappato dal suo taccuino, scrisse pochi versi a punta di matita. Avrebbe potuto scrivere una lettera; ma sarebbe riescita troppo voluminosa, e il vecchio carbonaro non avrebbe saputo dove nasconderla, mentre un bigliettino, convenientemente arrotolato, poteva celarsi da per tutto, anche in una cucitura ribattuta degli abiti.
Il biglietto del conte Gino alla marchesa Polissena diceva brevemente così:
«Saprete il caso che mi è toccato. Mi mandano a confine in Querciola, alle falde del Cimone, fuor del consorzio dei viventi… peggio ancora, lontano da Voi. Ne perderò la ragione; non mi parrà di vivere, fino a tanto non riceverò una vostra lettera. Il portatore di questo foglio mi è affezionato, e in qualunque modo mi farà avere i vostri caratteri. Addio! Mi si spezza il cuore, nel dover scrivere questa triste parola. Speriamo di mutarla in un arrivederci, e presto! Vi amo.»
Suggellò il biglietto, dopo averlo piegato più stretto che potè, e lo consegnò al fido Giuseppe.
– E dimmi, – gli soggiunse, – potrai farmi avere ad ogni modo la risposta?
– Non dubiti, illustrissimo; se una risposta ci sarà, gliela manderò certamente.
– Troverai persona fidata e sicura?
– Troverò tutto; Ella non si dia pensiero di ciò.
– Ad ogni modo, mi scriverai anche tu?
– Sì, illustrissimo; purchè Ella non rida della mia mano di scritto e dei miei errori d'italiano.
– Va là! – disse Gino. – Tu pensi da buon italiano, e questo è l'essenziale. —
Dopo di che, il giovanotto abbracciò il servitore e s'incamminò per la via dell'esilio. Erano le cinque dopo il meriggio, quando egli giunse a Fiumalbo,