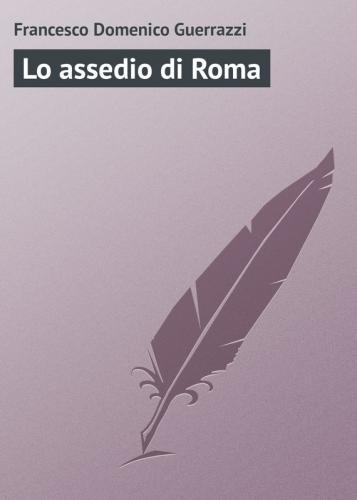E mentre combatteste voi, forse gli altri Italiani filavano? Comecchè raccolti tumultuariamente, nè soldati come voi altri in genere, in numero, e caso con tutte le regole forse non seppero i volontari combattere, morire, e vincere? – Perchè mai si licenziarono quasi gente immonda? E perchè a disfarli fu speso maggiore moneta, che non impiegarono a farli? E soldati sembra a voi che sarebbero quelli i quali voi v’ingegnate plasticare sul vostro modello? Hanno a difendere la Patria, e di Patria nulla hanno da sapere; li presumete soldati cittadini e li pretendete tali in procinto di avventarsi in battaglia, sentano lo sprone delle parole concitate del Capitano, e proibite poi che apprendano, più ancora, che ammirino i gesti degl’illustri capitani del popolo. Col popolo di cui sono sangue, e nel quale, superstiti, avranno a rientrare non piglino usanza; ne stieno appartati, dimentichino sè essere figli, o fratelli; soldati unicamente hanno da diventare; ma in cotesto modo educansi gladiatori non già soldati italiani; così si allevano i mastini affinchè guardino gli orti dai ladri non s’instituisce milizia onore a un punto e tutela della Patria. – Grave fatto è questo e come pieno d’ingiusta diffidenza così a Dio non piaccia, che partorisca funestissimi effetti: dunque temete che il popolo vi contamini i soldati? dunque o il popolo non più si accorda con voi, o voi col popolo? Eppure cotesto popolo volle liberissimo ieri il regno italico con a capo il reale di Savoia. Come! ieri consenso, ed oggi forza? Di già a questo? Ma i reami abbattuti quale altra legge avevano tranne la forza? E non bandiste voi, proprio voi, che un governo il quale si appoggia alla forza ormai non ha più causa, nè ragione di vita?
E tacendo del valore delle armi nè manco gli ordinamenti militari vostri paiono così saldi da presumere in grazia di questi la egemonìa sopra gli altri italiani, imperciocchè non entrando nel ginepraio del come si spenda il danaro, noi vediamo fare, e disfare la tela dello esercito, secondochè mutano di tessitore; ed anco qui prego Dio, che non voglia, che invece di tessere una veste nuziale, il Ministro o piuttosto i Ministri non ci ammanniscano una Sindone, la quale sarebbe causa non già di adorazione, bensì di esecrazione perpetua.
Insomma se i Piemontesi sè amano e noi, e lo vogliamo credere, importa, che smettano il vezzo di presumere sè chioccia, e noi uova da lasciarci covare. Noi non patiremo certo nè tribù di Levi, ne tribù di Beniamino: fratelli vi amiamo, compagni vi accettiamo, disuguali no, molto meno padroni. Se la casa di Savoia diè lo Statuto al regno, ricordate come non fosse concessione sibbene restituzione; se lo mantenne Vittorio Emanuele il cuore e il senno lo sovvennero nello adempimento del debito suo, e n’ebbe rimerito di fama, titolo unico tra quanti apparvero principi sopra la terra, riconoscenza di popoli, e stato, che lo renderà superiore a molti potentati, inferiore ad alcuno. Nè noi neghiamo, anzi confessiamo volentieri, non mediocre conforto essere venuto agli spiriti liberali d’Italia vedere sempre ritta la bandiera italica in Piemonte, comecchè spesso pendente già lungo la stacca a mo’ di vela nelle uggiose calme dell’Atlantico; e confessiamo altresì che quivi il talento per volere sia stato pari alla fortuna per potere, dacchè se la vostra terra non si fosse distesa oltre il crine delle Alpi, e a verun patto potesse sopportarla la Francia in mano all’Austria, voi come noi avreste dovuto con la morte nel cuore piegare il collo alla maligna onnipotenza dei fati. Come no? Perchè lo neghereste prosuntuosi? Le mura di Alessandria non rimasero contaminate da presidio tedesco?
Comprendo ottimamente avere a sonare le mie parole rudi; e giova appunto che sia così; gli adulatori dei popoli più funesti due cotanti, che quelli di un re, avvegnadio questi possa cessare da un punto all’altro, e allora morta la vipera spento il veleno, mentre il popolo forse dura fino alla consumazione dei secoli. Callimaco Esperiente nella vita di Attila racconta come il poeta Marullo avendo composto un poema (immaginate che poema!) in lode di cotesto Unno glielo presentasse a Padova fiducioso di premio, ma quando Attila seppe come costui lo facesse derivare da Dio, e lui medesimo salutasse Dio ordinò che poema, e poeta gittassero sul fuoco; ora il popolo nostro civile si approfitti dello esempio del condottiero barbaro emendandolo secondo la ragione dei tempi; lasci stare il fuoco, ma un tuffo nell’acqua ai suoi adulatori lo potrebbe dare. Io parlo per dire il vero, non per odio di altrui, nè per disprezzo, e se paleso animoso le gozzaie, mi muove studio di ovviare che intristiscano, anzi scompaiano. Fatuità somma credere, come oggi si costuma, che negando un danno possa torsi che sia: così quando schiamazzano la Italia è ricca confidano, che ciò empia le casse; ovvero la Italia ormai non può più disfarsi, e con questo pensano averla assicurata con nodo indissolubile: se simile insania non fosse per partorire funestissimi mali non varrebbe il pregio riprenderla, e nè anco indicarla, ma all’opposto io temo, che possa disfarsi perdendo occasione, che forse non si presenterebbe per più secoli a questa parte. Il passaggio in mezzo alle rivoluzioni assai si rassomiglia alla prova del fuoco, dove se ci era via a salvamento consisteva nel traversare del campione tutto, e di rincorsa, lo spazio incendiato. E bazza se allora le scottature erano poche! Se si fermava un’attimo, di lui non rinvenivi nè manco la cenere. Nei primi tempi delle rivoluzioni molti interessi laceri, o coperto, o palese travagliano lo stato novello; e da per tutto vedi scompiglio: ora preme più che mai in questo periodo climaterico l’universale trovi qualche compenso ai patimenti inevitabili; se gli assottigli il pane e tu ministragli copia più larga di libertà; se esigi piamente spietato il tributo di sangue, e tu mostra, ch’egli è per francare la Patria dalla dominazione straniera; la contentezza futura fa toccare con mano, che uscirà dal seme del disagio presente; i membri sparsi di un popolo ridotti come fratelli in una famiglia sola non pure soddisfano al precetto della religione, non pure all’ultimo provvederanno alla pubblica ed alla privata economia, ma altresì acquisteranno la potenza in ogni tempo necessaria, non già (Dio ne guardi!) ad offendere altrui, sì bene a difendere noi stessi. La divisione nostra risponde al Tedesco confitto nella Venezia, allo Spielberg, alle verghe, alle forche, alle fucilazioni, e forse, più amaro che questo, agli strazi quotidiani della gente galla.
Nello stare strettamente uniti è posta la salute d’Italia; nè la pena di Beltramo dal Bornio, che per avere con arti scellerate diviso il figlio dal padre il Dante immagina vagolare per lo inferno, con in mano il capo tronco dal suo corpo la reputo sufficiente a cui intenda separare parte d’Italia dalla Italia. Se mi mostro, e sono implacabile contro colui, che la scemò a settentrione non meno irrequieto per quanto io valga, inchioderò nella infamia chi la menomasse a mezzogiorno; molto più, che questi non potrebbe nè anco allegare in discolpa il pretesto della necessità: non a dividere pertanto, bensì per istringere io muovo parole, persuaso, che la compagnia non dura fra genti con varia ragione aggravate; meglio vale, anzi unicamente vale, che il troppo carico dica: «io non ne posso più, fratello vienmi in aita;» che infellonirsi tacendo, e buttare via dalle spalle la soma con iattura di tutti.
Noi tutti della famiglia italiana possediamo in copia vizi e virtù sovente diversi, qualche volta contrari, mettiamo in comunella ogni cosa; nelle mutue virtù ci educhiamo, dei vizi scambievoli emendiamoci. Piacemi dirlo: avendo per quanto mi fu dato ricerco la natura del popolo torinese io lo trovai onesto, e più lo era prima che l’alito corruttore del Cavour ci soffiasse sopra; nel commercio singolare, invece, che presuntuoso confessa sentirsi d’ingegno inferiore, e chiede che tu lo chiarisca; se non che la moltitudine delle parole gl’introna lo intelletto peggio, che i tamburi gli orecchi; le immagini lo abbarbagliano, lo sgomentano i tropi; teme i farabulloni lo scarrucolino, i parabolani lo abbindolino, ed ha ragione; chiede definizioni esatte, argomenti precisi; insomma con la sua gamba tu regola il tuo passo; e se lo fai ti si professa grato: il concetto compreso egli si mura dentro il cervello col gesso da presa: forse fie l’ultimo a cessare fede nel governo monarchico, ma cessata ch’ei l’abbia non valgono ganci a ripescarla. Alle amicizie nè facile, nè subito; non ti trabocca giù il suo liquore cordiale da empirtene il bicchiere, e allagarne la mensa, ma se te ne versa mezzo, e’ lo fa per dartene il rimanente un’altra volta: forse, almeno io provai così, con veruno