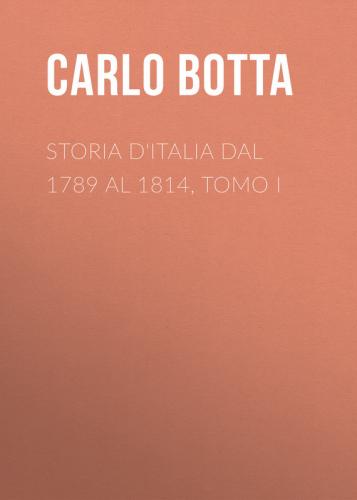Storia d'Italia dal 1789 al 1814, tomo I
LIBRO PRIMO
Proposito dell'opera. Stato d'Italia nel 1789. Come siano nati gli ordini feudali; poi come moderati. Opinioni ed inclinazioni del secolo in questa materia. Stato della religione; perchè fu soppressa la società dei gesuiti, e quali effetti siano nati da questa soppressione. Lodi di Giuseppe II imperatore d'Alemagna, e riforme fatte da lui. Viaggio di papa Pio VI a Vienna. Buon governo del ducato di Milano sotto il conte di Firmian. Lodi di Leopoldo gran duca di Toscana; sue numerose ed utili riforme; felice condizione del popolo sotto questo principe. Dottrine di Scipione de' Ricci vescovo di Pistoia, e del suo sinodo. Quali effetti partoriscano queste dottrine sulla corte di Roma. Stato del regno di Napoli; amministrazione del marchese Tanucci; opinioni che vi regnavano; riforme eseguite, o sperate. Stato, e parlamento di Sicilia. Stato del ducato di Parma sotto i duchi don Filippo e don Ferdinando: buona amministrazione di Dutillot. Condizioni di Roma e delle romane cose: disegni che vi si facevano: qualità di Pio VI; sua magnificenza; suoi sforzi pel prosciugamento delle paludi Pontine. Stato del Piemonte; qualità di Vittorio Amedeo III re di Sardegna; suoi ordinamenti sui soldati, sull'amministrazione, sulle finanze. Stato della repubblica di Venezia; natura del suo governo, e de' suoi popoli. Condizioni della repubblica di Genova, poi di quelle di Lucca, e di San Marino. Stato del ducato di Modena, e qualità del suo principe, Ercole Rinaldo d'Este. Sunto generale delle opinioni, ch'erano prevalse in Italia nel 1789.
Proponendomi io di scrivere la storia delle cose succedute in Italia ai tempi nostri, non so quello che gli uomini della presente età saran per dire di me. Conciossiachè mancati col finire del decimo sesto secolo gli eccellenti storici fiorentini, i quali soli forse fra gli storici di tutti i tempi e di tutte le nazioni scrissero senza studio di parti la verità, i tempi andarono sì fattamente peggiorandosi, e l'adulazione in guisa tale distendendosi, che il volere scrivere la storia con sincerità pare opera piuttosto incredibile, che maravigliosa. E non so perch'io m'oda dire tuttavia, che la storia è il lume del tempo, e che insegna bene il fatto loro ai popoli, ed ai principi: imperciocchè, scritta secondo il costume che prevalse, io non so quale altra cosa ella possa insegnare altrui, fuori che a dir le bugie; e qual buona guida nel malagevole cammino della nostra vita siano queste, ognun sel vede, stantechè i negozi umani con la realtà si governano, non con le chimere. E già i più tra coloro ai quali io appalesai questo mio pensiero, mi dissero apertamente o ch'io non oserei, o ch'io non potrei, od all'ultimo ch'io non dovrei mandarlo ad esecuzione. Pure, pare a me, che se l'adulazione si cerca da una parte, che certamente si cerca, molto ancora più si offra dall'altra, e che più ancora siano da accagionarsi di viltà gli scrittori, che di rigore, o di ambizione i principi. Per la qual cosa io, che di maggior libertà nello scrivere non pretendo di godermi di quella, cui Benedetto Varchi, o Francesco Guicciardini ottennero dal duca Cosimo, e Niccolò Machiavelli dal pontefice romano, il quale concesse anco un amplissimo privilegio per la stampa delle sue opere, mi confido che comportare mi si possa: salvochè si voglia credere, od almeno dire, ciò che credeva e diceva colui, che ai nostri dì avrebbe voluto spegnere anco il nome della libertà, cioè che tutto il male (così chiamava egli il desiderio mostrato prima dai principi, poscia dai popoli, di un governo più benigno) procedette dal secolo di Leone X. Che se ad alcuni sembrasse essere le cose più tenere oggidì, che ai tempi passati, dirò che anche allora furono, come negli anni vicini a noi, massime nella misera Italia, inondazioni di eserciti forestieri, arsioni di città, rapine di popoli, devastazioni di provincie, sovvertimenti di stati, e fazioni, e sette, e congiure, ed ambizioni crudeli, ed avarizie ladre, e debolezze di governi effeminati, e fraudi di reggimenti iniqui, e sfrenatezze di popoli scatenati. Per me, sonmi del tutto risoluto, se a tanto si estenderanno le forze del mio ingegno, a mandare ai posteri con verità la compassionevol trama di tanti accidenti atroci, di cui la memoria sola ancora ci sgomenta. Seguane poi ciò che vuole: che la vita è breve, ed il contento di avere adempiute le parti che a buono e fedele storico si appartengono, è grande, e quasi infinito. Oltrechè di conforto non poco sarammi il raccontare, come farò, con uguale sincerità le cose liete, utili, e grandi, che fra tanti lagrimevoli casi si operarono per un benigno risguardo della divina providenza che mai non abbandona del tutto i miseri mortali.
L'Europa conquistata dai re barbari fu data in preda ai capitani loro; uomini e terre caddero in potestà di questi. Così se ai tempi romani le generazioni erano partite in uomini liberi, e schiavi, ai tempi barbari furono divise in conquistatori, e servi. Tale è l'origine degli ordini feudali. Teodorico re de' Goti moderò una tal condizione coll'avere istituito i municipii. Poi gli ecclesiastici diventati ricchi fecero ordine, e mitigarono, dividendola, o contrastandola, l'autorità feudale. Così sorsero gli ordini, o stati, o bracci, che si voglian nominare, della nobiltà, del clero, e dei comuni. Carlo V gli spense nella Spagna, ma non potè nell'isole d'Italia; i Borboni gli conservarono in Francia, servendosene più o meno, secondo i tempi. Nell'Italia divisa in tanti stati, e sì spesso preda di principi forestieri, che a fine di tenerla accarezzavano pochi potenti per assicurarsi dei più, l'autorità municipale, se si eccettuano alcune antiche repubbliche, si mantenne più ristretta, la feudale più larga. Ciò quanto allo stato. Rispetto ai particolari restavano ancora non pochi vestigi dell'antico servaggio, tanto circa le cose, quanto circa le persone. Di questi, alcuni andarono in disuso per opinione de' popoli, o per benignità dei feudatarii; altri furono aboliti dai principi: dei superstiti, il secolo, di cui abbiamo veduto il fine, voleva l'annullazione.
Nè in questo si contenevano i desiderii dei popoli. Volevasi una equalità quanto alla giustizia, e quanto ai carichi dello stato; nella quale inclinazione concorrevano non solamente coloro ai quali questa equalità era profittevole, ma eziandio la maggior parte di quelli, che si godevano i privilegi. Dire poi, come alcuni hanno scritto, e probabilmente non creduto, che si volesse una equalità di tutto, ed anche di beni, fu improntitudine d'uomini addetti a sette, soliti sempre a non guardare quel che dicono, purchè dicano cose che possano infiammare i popoli, e farli correre alle armi civili. Queste erano le quistioni dei diritti; e sarà da quinc'innanzi cosa luttuosissima al pensarci, e degna di eterne lagrime, che col progresso di tempo siansi alle quistioni medesime mescolate certe altre astrattezze, e sofisterie, che insegnarono alla moltitudine il voler fare da se, quantunque si sapesse che la moltitudine commette il male volentieri, e si ficca anco spesso il coltello nel petto da se: tanto i moti suoi sono incomposti, i voleri discordi, le fantasie accendibili, e tanto ancora sopra di lei possono sempre più gli ambiziosi, che i modesti cittadini.
La religione medesima era già trascorsa, non già nel dogma, che sempre rimase inconcusso, ma bensì nella disciplina. Dolevansi i popoli che gli utili operai della vigna del Signore fossero poveri, mentre gli oziosi se ne vivevano in grandi ricchezze, delle quali non solo usavano, ma spesso ancora abusavano: dolevansi essere i primi insufficienti per numero, o per mala distribuzione delle cariche, i secondi eccessivi; dolevansi di certe pratiche religiose, più utili a chi le metteva su che decorose pel divin culto, mentre per queste era nel medesimo tempo scemato maestà e frequenza alle più gravi e necessarie solennità della chiesa: scandalizzarsene le anime pie, darsi cagion di calunnia agli empi, ed agli acattolici.
Ma ben altri discorsi si facevano, massimamente in Italia, i quali tutti nascevano da quella inclinazione del secolo favorevole ai più. Era stata soppressa la società di Gesù, perchè era divenuta formidabile ai principi, e perchè faceva coll'autorità sua, e co' suoi maneggi formidabile di soverchio ai medesimi la corte di Roma. Imperciocchè, mescolate le profane cose con le divine, temevano i principi cattolici, che siccome era una monarchia universale spirituale di cui era capo il sommo pontefice, così venisse a nascere per mezzo dei gesuiti, tanto attivi, e tanto sagaci operatori per la santa sede, una forma di monarchia universale temporale, in cui avesse il capo della fede cattolica più autorità, che gli si convenisse. Vedevasi il sommo pontefice Clemente XIV, che lo spegnere i gesuiti era un privarsi della più efficace milizia che s'avesse: con tutto ciò non potè resistere alle esortazioni ed alle minacce di tanti principi potenti di forze, celebrati per pietà, formidabili per concordia. Pure stette lungo tempo in forse; finalmente consentì, poi fra breve si pentì. Ma seguitonne a timore del papa, ed a contentezza dei principi maggior effetto, che quello e questi non avevano creduto; poichè ne sorse più viva nel corpo della chiesa la parte popolare. Parlossi di doversi ridurre alla semplicità antica la chiesa di Cristo; allargare la autorità de' vescovi e dei parrochi; scemar quella del pontefice sommo, nè doversi più tollerare il romano fasto.